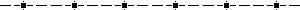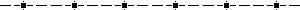
Rilevamento Dati
| Contenuto e aspetto delle carte |
| Il reticolato geografico |
| La scala |
| Il rilievo |
| La proiezione cartografica |
| I metodi per realizzare una carta geografica |
| L'osservazione |
| Compilazione e riproduzione |
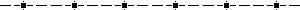
Contenuto e aspetto delle carte
La carta è una composizione figurativa costituita da punti e linee grafici e da spazi delimitati, aree dette campiture nella terminologia cartografica, distinte da colori, oppure da tratteggi e punteggiature se la carta è in un solo colore. Il contenuto è anzitutto formato dalla planimetria, cioè il disegno degli oggetti con prevalente sviluppo orizzontale, quindi la costa e i corsi d'acqua, le vie di comunicazione, gli edifici singoli o riuniti in centri abitati fin alle città, i confini politici ed amministrativi, ed anche la vegetazione, ecc. Nel caso dei mari la planimetria si limita al contorno. Non sempre la carta contiene la figurazione dell'altimetria, ossia l'orografia o rilievo. Quasi sempre la carta è corredata da scritture per i nomi di luogo e degli oggetti geografici in genere. Le carte senza nomi, dette mute, servono a scopo didattico oppure come fondo topografico di carte tematiche. Elementi complementari sono la scala e la tabella di spiegazione dei segni convenzionali, compresi i colori delle campiture. La tabella il più spesso manca nelle carte del terreno in piccola scala, perché poco numerosa è la varietà dei segni, facilmente interpretabili e da tutti ben conosciuti. Un elemento che non dovrebbe esser tralasciato è la scala; in mancanza di questa indicazione la scala può essere ricavata dalla lunghezza del grado di meridiano, ricordando però che nelle carte in piccola scala, che abbracciano spazi piuttosto ampi, il rapporto di riduzione è variabile. Non dovrebbe poi mancare nelle carte topografiche in grande scala la data del rilevamento o ultimo aggiornamento. Nelle carte tematiche la data può aver la funzione d'indicare fino a qual momento è stato tenuto conto delle conoscenze su un determinato tema.
Per la costruzione di una carta è fondamentale avere un sistema di riferimento a cui riportare gli elementi da rappresentare. Tale sistema, utilizzato per la prima volta da Tolomeo, è quello del reticolo di meridiani e paralleli: linee immaginarie che circondano il globo terrestre in senso tra loro perpendicolare. I meridiani si ricavano pensando di sezionare il globo verticalmente, da un polo all'altro, come si usa fare quando si affetta un'anguria; i paralleli si ricavano invece immaginando di sezionare la Terra orizzontalmente ossia trasversalmente ai meridiani. Questi danno la latitudine, i meridiani la longitudine.
Convenzionalmente la longitudine si calcola in 180° est e 180° ovest a partire dagli 0° del meridiano di Greenwich, Inghilterra. La latitudine è indicata in 90° nord e 90° sud a partire dal parallelo 0°, rappresentato dall'equatore. Qualsiasi punto della carta può essere definito con precisione ricorrendo a gradi, minuti e secondi di latitudine e longitudine. Le carte sono generalmente orientate con il nord nella parte superiore e sono dotate del disegno di una bussola o di altre forme di indicatore, che consente di individuare il polo magnetico settentrionale.
La scala della carta geografica offre la chiave per tradurre la distanza di due punti sulla carta nella distanza reale che sulla superficie terrestre divide tali punti. La scala è solitamente rappresentata da una frazione. Per esempio, scala 1:100.000 significa che ciascuna unità di misura della carta (diciamo 1 centimetro) rappresenta 100.000 unità di misura nella realtà (nel nostro esempio 100.000 centimetri, cioè 1 chilometro). Solitamente la scala è indicata al margine della carta accanto a un segmento delimitato che può corrispondere a una distanza quale 1, 5, 10 o 100 chilometri.
Uno dei maggiori problemi che sin dalle origini si sono imposti ai cartografi è stato la rappresentazione del rilievo, cioè di colline e montagne, valli e gole. Nelle prime carte geografiche i rilievi erano rappresentati in maniera generica, senza alcuna precisione. Questa si è avuta soltanto dopo l'introduzione delle cosiddette curve di livello, o isoipse. Le curve di livello sono delle linee curve che collegano sulla carta tutti i punti posti alla medesima quota altimetrica: l'intervallo di livello può essere scelto liberamente (generalmente in funzione del tipo di rilievo e della scala della carta). Nel caso di un intervallo fissato in 50 metri le curve di livello indicheranno tutti i livelli multipli della misura di riferimento (50, 100, 150 m ecc.). Le curve di livello assicurano una rappresentazione accurata dei rilievi.
Altri metodi per indicare i rilievi del terreno prevedono il ricorso a colori (tinte altimetriche) e ombre, al rilievo a sfumo e al rilievo a tratteggio. Quando vengono utilizzati i colori si ricorre solitamente a una scala di intensità decrescente collegata in ciascuna tonalità a un'altezza media; per esempio, tutto il terreno compreso tra 0 e 100 m viene colorato in verde chiaro, quello tra 100 e 200 m in verde medio e così via.
Per rappresentare l'intera superficie della Terra senza alcun tipo di distorsione una carta geografica dovrebbe avere una superficie sferica; una carta di questo tipo è il mappamondo o globo, che però è ingombrante, di poco uso pratico, e non consente molti dettagli. Per questo si ricorre alle carte, le quali però hanno il difetto che, in quanto superfici piane, non possono rappresentare in maniera accurata la superficie della Terra se non in sezioni di dimensioni ridotte, in cui l'effetto della curvatura terrestre risulta trascurabile.
Per descrivere una porzione importante della superficie terrestre in maniera accurata la carta deve essere disegnata in maniera da ottenere un compromesso tra distorsione delle superfici, distanza e direzione. Talvolta un cartografo decide di ricercare l'accuratezza in uno solo di questi caratteri a spese degli altri elementi. I vari metodi utilizzati per riprodurre la superficie terrestre su una superficie piana sono conosciuti come proiezioni che, a seconda della tecnica impiegata, vengono classificate come geometriche o analitiche. Le proiezioni geometriche vengono classificate in relazione al tipo di superficie che devono rappresentare e indicate come proiezioni di sviluppo cilindriche, coniche o piane. Le proiezioni piane sono note anche come proiezioni azimutali o zenitali. Le proiezioni analitiche sono sviluppate sulla base di calcoli matematici.
Nel realizzare una proiezione cilindrica il cartografo immagina la carta come un cilindro che circonda la Terra appoggiandosi all'equatore. I paralleli di latitudine sono la proiezione sullo stesso cilindro dei piani paralleli che tagliano il globo. A causa della curvatura della Terra, avvicinandosi ai poli i paralleli si avvicineranno progressivamente tra loro mentre i meridiani verranno rappresentati come una sequenza di linee parallele perpendicolari all'equatore. Dopo aver completato la proiezione immaginiamo che il cilindro venga tagliato verticalmente e srotolato sul piano. Il risultato è quello di una carta che rappresenta la superficie terrestre come un rettangolo con le linee di longitudine parallele ed equidistanti e quelle di latitudine anch'esse parallele ma non equidistanti: per quanto le forme delle superfici siano distorte in maniera crescente via via che ci si avvicina ai poli, le superfici relative tra le diverse aree sono equivalenti a quelle calcolate sul mappamondo.
La proiezione di Mercatore, sviluppata appunto dal cartografo fiammingo Gerardo Mercatore è strettamente collegata, pur con qualche adattamento, alla proiezione cilindrica. Una carta di questo tipo è accurata nelle regioni equatoriali ma notevolmente distorta alle alte latitudini. Le direzioni sono comunque rappresentate in maniera fedele e per questo le carte costruite su proiezioni cilindriche sono particolarmente apprezzate e usate dai naviganti (categoria cui le carte di Mercatore erano inizialmente rivolte). Ciascuna linea che taglia due o più meridiani con lo stesso angolo è rappresentata nelle carte di Mercatore come una linea retta. Questa linea viene chiamata linea lossodromica e rappresenta la rotta ideale di una nave o di un aereo che seguono senza correzioni le indicazioni fissate dalla bussola.

Deriva dalla proiezione del globo su un piano con cui può entrare in contatto in un punto qualsiasi. Questo gruppo comprende le proiezioni gnomoniche, ortografiche e stereografiche. Altre due proiezioni piane sono note come azimutali di area equivalente e azimutali equidistanti: non possono essere proiettate ma si sviluppano in una tangente piana. La proiezione gnomonica, o centrografica, è prodotta da una sorgente luminosa immaginaria posta al centro della Terra, mentre in quella ortografica la fonte di proiezione è posta all'infinito. La posizione della fonte luminosa nella proiezione stereografica è quella del punto antipodico a quello di tangenza della sfera con il foglio sul quale viene realizzata.
La natura della proiezione varia in funzione della fonte che si sceglie per realizzarla. La proiezione gnomonica copre un'area inferiore a metà di un emisfero, la proiezione ortografica copre un intero emisfero, la azimutale di area equivalente e la stereografica possono coprire superfici maggiori, mentre la azimutale equidistante può rappresentare l'intero globo terrestre. In tutte queste proiezioni (con la sola eccezione dell'azimutale equidistante), la porzione di Terra rappresentata dipenderà dal punto di contatto scelto tra il piano immaginario e la Terra stessa. Una proiezione piana tangente con il piano all'equatore rappresenterà appunto la zona equatoriale ma non sarà in grado di rappresentarla nella sua interezza su una sola carta; se il punto di tangenza sarà invece uno dei due poli, la carta rappresenterà la corrispondente regione polare.
Nel preparare una proiezione di sviluppo di questo tipo si deve immaginare di porre la sfera terrestre dentro un solido di forma conica, di collocare all'interno della sfera stessa la sorgente luminosa proiettante il reticolato sulla superficie del solido e quindi di tagliare lungo una generatrice questa superficie per poi svolgerla in una superficie piana. Il solido è tangente con la sfera terrestre in tutti i punti di uno stesso parallelo di latitudine e sarà proprio quella la zona di maggior accuratezza della carta che verrà prodotta mentre la distorsione andrà crescendo via via che ci si allontana dal parallelo di tangenza.
Notevolmente più precisa ma assai più complessa da realizzare è la proiezione policonica, in cui si immagina una serie di coni, ciascuno dei quali è tangente alla Terra in un diverso parallelo di latitudine. La carta che ne deriva sarà composta dalla somma dei singoli rilevamenti, adattandosi soprattutto all'analisi comparativa di aree non particolarmente estese che si sviluppano nelle zone temperate del pianeta.
Per realizzare le carte della superficie terrestre sono state elaborate alcune proiezioni dette a sviluppo matematico. Queste carte rappresentano l'intera superficie della Terra in forma di cerchi, ovali e in altre forme. Ricorrendo a questi metodi la Terra non viene rappresentata nella forma tradizionale di una proiezione ma appare come l'assemblaggio di una serie di frazioni di dimensioni irregolari. Vengono chiamate anche carte a proiezione interrotta.
Attraverso complesse elaborazioni matematiche si può così rappresentare su una superficie piana, qualsiasi punto del globo a cui associare molteplici informazioni.
I metodi per realizzare una carta geografica
La cartografia ha subito enormi e rapidissimi sviluppi soprattutto a partire dalla seconda guerra mondiale. Le nuove tecnologie utilizzate per la raccolta delle informazioni, la fotografia aerea e satellitare, le triangolazioni satellitari rese disponibili dal sistema GPS (Global Positioning System) hanno sensibilmente ridotto i margini di errore nella determinazione dei punti sulla superficie della Terra. Tra le grandi innovazioni di questi anni non va dimenticato il ricorso al computer per il disegno di precisione delle carte.
Una volta raccolte le informazioni deve essere compiuta un'attenta pianificazione per assicurarsi che tutte le indicazioni rilevanti siano esposte con chiarezza e in maniera accurata. I dati raccolti vengono inseriti in forma di punti in una griglia realizzata sulla base della proiezione piana o di sviluppo che si è adottato. I rilievi sono indicati, quando richiesto, facendo ricorso alle curve di livello che vengono tracciate utilizzando coppie di fotografie stereoscopiche. Nello stesso modo si tracciano le strade, i fiumi e via via tutti gli altri elementi di riferimento. La preparazione finale della carta geografica prevede la realizzazione di una serie di pellicole colorate sulle quali i vari simboli vengono tracciati con la tecnica della litografia.