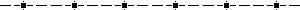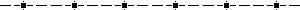
Classificazione carte
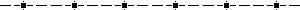
Classificazione delle carte secondo la scala
Le scale tipiche per gli impieghi propri dell’ingegnere, dell'architetto, del geometra, dell'urbanista sono quelle medio grandi, ovvero dal 25 000 al 2 000. Le carte a scala maggiore (e quindi a denominatore minore, come 1000, 500 e anche 200) servono più per la progettazione che non per scopi generali. Spesso tali carte non sono nemmeno compilate con i criteri della cartografia: riguardando in genere porzioni limitate di superficie fisica della Terra (centri storici, lottizzazioni, sistemazioni del terreno ecc.), sono delle vere e proprie proiezioni mongiane su di un piano medio locale; senza quindi deformazioni cartografiche, e perciò spesso anche riferite a reticolati ortogonali locali, non inseribili nelle cartografie generali se non con procedure di rototraslazione rigida, allorché se ne presentasse il caso, e previa naturalmente riduzione di scala nonché sfoltimento di particolari.
Le carte possono distinguersi in vari tipi o classi e se ne può dare una classificazione. Ma data la loro grande varietà e complessità i criteri di base per la classificazione sono molteplici e quindi noti si riesce ad ottenerne una veramente globale, anche a non tener conto delle sfumature, di casi cioè di transizione, che rendono incerta la classificazione. Ad ogni modo è utile procedere a una ripartizione secondo taluni criteri più semplici, e in primo luogo quello della scala. In Italia è comunemente in uso la seguente:
| Grandi carte topografiche |
| Carte topografiche, militari, urbanistiche, ecc. |
| Strumenti urbanistici generali |
| Strumenti urbanistici esecutivi |
| Disegni architettonici di larga massima |
La carta in scala 1:100000 è la carta fondamentale d'Italia. Carta di grande precisione e densità di Informazioni contiene numerosi particolari riportati ovviamente con annotazioni simbologiche e quindi presumendo che la loro grandezza naturale in quanto, in tal caso, acquisterebbero dimensioni così piccole da essere illeggibili. La carta che può raffigurare nel loro insieme i territori di alcune provincie, di vasta zone omogenee, di comprensori. Su queste si individuano le grandi infrastrutture territoriali sovracomunali, le zone di vincolo speciale quali i parchi regionali e nazionali ecc.

Carte topografiche, militari, urbanistiche, ecc.
In scala l:25000 è rappresentato il mosaico coprente l'intero territorio nazionale della Carta d'Italia, a cura dell'istituto Geografico Militare (I.G.M.). Questa carta riporta la curve di livello con equidistanza di 25 m quando lo isoipse sono disegnate continue, e con equidistanza di 5 m quando le isoipse sono disegnate a tratti; nonchè l'altimetria espressa in metri o riferita al livello del mare (medio) . La cartografia alla scala l:25000 costituisce la carta topografica fondamentale direttamente rilevata dal terreno (anticamente col metodo topografico, recentemente col metodo fotogrammetrico dalla quale derivano tutte lo altre carte a scala minore (1:50000, 1:1000000, l:200000). La carta I.G.M. in scala 1:50000, derivando direttamente da quella 1:25000, conserva un alto grado di precisione, con un gran numero di particolari.
Strumenti urbanistici generali
Le cartografie in scala l:5000 e l:10000 sono generalmente usate per rappresentare porzioni di territorio nel suo insieme sia urbano che extraurbano. Potendo coprire con una sola mappa l'intero territorio di molti Comuni, sono le carte usate per la raccolta dei dati (cartografia d'indagine) e per la stesura (cartografia progettuale) dei Piani Regolatori Generali. In queste mappe sono individuate le zone soggette a progettazione particolareggiata mediante i Piani Urbanistici Esecutivi. In tali scale, era rappresentata l'unica cartografia di base di molti Comuni: oggi si tende ad arricchire il patrimonio cartografico comunale integrandolo con cartografie in scala 1 :2000 ed 1:1000 per i nuclei abitati, ed i 1:500 per le zone più problematiche e complesse (es. centri storici). La scala 1:10000 pare la piú adatta per descrivere e rappresentare le realtà extraurbane. Trattandosi di una carta sintetica essa può formare una cartografia generale di base per la raccolta dei dati sull'uso del suolo, lo stato di fatto, le prescrizioni di piano, la grande viabilità, ecc. In essa si evidenziano le localizzazioni degli agglomerati urbani, la morfologia del territorio, i caratteri topografici, pedologici, geologici, ecc. Nella carta in scala 1:5000 sono chiaramente leggibili i vari tipi di tessuto urbano che compongono la città, le trame viarie, i rapporti tra i pieni e i vuoti, ecc. consentendo di risalire alla lettura dei successivi strati storici, alla loro morfologia ed aggregazione. Molte carte tematiche utili alla Pianiricazíone a livello Comunale, sono redatte in queste scale.
Strumenti urbanistici esecutivi
Sono le scale usate prevalentemente nei diversi tipi di cartografia a grande scala, quali ad esempio quelle catastali attuali, sia per il N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano), sia per il N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni). La planimetria catastale è sempre parte indispensabile per il corredo iconografico occorrente per ottonere una concessione edilizia. In queste scale vengono redatti i Piani Urbanistici Esecutivi. Forse la carta più emblematica della serie è la carta In scala 1:2000 che può essere considerata la carta di base per gli studi di programmazione urbanistica e per altri impieghi quali ad esempio la progettazione urbana affiancata da parti in scala 1:1000 o addirittura 1:500 per la descrizione di aree particolari quali zone densamente costruite come i centri storici.
Disegni architettonici di larga massima
La scala 1:500 è la scala che unisce i due versanti dell'urbanistica e dell’architettura, in quanto relaziona la rappresentazione del singolo oggetto edilizio ed il contesto ambientale. Questa scala infatti viene utilizzata nei disegni di progetto di larga massima, in edifici o complessi di edifici di notevoli dimensioni. In questi casi si tende infatti a rendere una chiara idea morfologica e dimensionale dell'oggetto architettonico, la distribuzione interna e la destinazione d'uso degli ambienti. La planimetria generale di un edificio, generalmente redatta in scala 1:500, ha il compito di esprimere il rapporto intercorrente tra l'oggetto architettonico o l'ambiente circostante. Si rappresentano infatti le distanze dell'edificio dai confini, la viabilità interna e di accesso al lotto quali passaggi pedonali, carrai, veicolari, parcheggi pubblici o privati, ecc., si evidenziano inoltre i diversi usi dette aree libere tra cui le destinazioni quali il verde pubblico, verde consortile, verde condominiale verde privato ecc. descrivendone le attrezzature: giochi bimbi, attrezzature sportive, di sosta, alberature, siepi, momenti d’acqua, ecc; i tipi di pavimentazione, le infrastrutture primarie quali strade, passaggi pedonali, fognature bianche, nere o miste, elettrodotti, gasdotti, rete telefonica completa di punti di attacco tra la rete pubblica e gli edifici, nonchè dei pozzetti d'ispezione o di adduzione di ogni tipo d'impianto, ecc.; le recinzioni, le alberature, la natura del terreno, eventuali viste sul paesaggio, nonchè le pendenze espresso mediante quote altimetriche o curve di livello. La planimetria in scala 1:500 deve inoltre riportare tutte le quote planimetriche utili alla lettura, sia dell'edificio che del contesto. La scala 1:500 è adottata prevalentemente nelle tavole descrittive del progetti del Piani Urbanistici Esecutivi, infatti è il supporto ideale per la cartografia di base di porzioni di territorio densamente edificato ad es. : i centri storici, i nuclei produttivi, ecc.
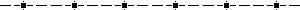
Carte topografiche e carte tematiche
Un'altra e importante distinzione procede dal tipo di oggetto o fenomeno rappresentato, o messo in speciale risalto. Ne deriva la divisione in due grandi classi, sulle quali tutti sono d'accordo:
| carte topografiche |
| carte tematiche. |
Carte topografiche è qui da intendersi in senso tutto diverso da quello sopra indicato a proposito della scala. Nell'uso internazionale sono oramai designate carte topografiche le rappresentazioni della superficie fisica, materiale, della Terra, costituita dal terreno e dallo specchio delle acque (o dal fondo del mare o dei laghi), senza alcun riguardo alla scala, così anche un planisfero può rientrare in questa categoria. Tali carte rappresentano la posizione, le dimensioni, le forme del terreno, compreso quanto vi si trova di oggetti concreti e durevoli (edifici, strade, ecc., ma anche vegetazione, ecc.). Non a torto sono state pure chiamate carte del terreno, espressione che adopreremo nel caso di possibili equivoci. In sostanza le carte topografiche raffigurano oggetti immediatamente visibili, tanto che sul luogo si rende facile la comparazione tra carta e realtà. Normalmente contengono anche altre indicazioni, immateriali, come i confini politici e amministrativi; altro elemento immateriale, e dal punto di vista pratico nient'affatto secondario, è costituito dai nomi di luogo, il cui insieme in una certa regione costituisce la sua toponomastica. Ma anche il fondo marino, rappresentato con tinte batimetriche o altrimenti, non è immediatamente visibile, benché concreto. Per lungo tempo si sono conosciute soltanto le carte del terreno. Oggi hanno preso largo sviluppo le carte tematiche.
Carte tematiche rappresentazioni di fenomeni concreti visibili o non, oppure di concezioni astratte, qualitative o quantitative, e comunque con limitazione ad un solo tema specifico o a pochissimi, ad esempio la temperatura dell'aria nello strato presso il suolo, le correnti marine, le associazioni vegetali, la densità della popolazione, le produzioni agricole, perfino certi rapporti politici internazionali, ecc. Appunto perché dedicate ad un tema specifico sono state chiamate (prima dai Tedeschi) carte tematiche, denominazione che nell'ultimo trentennio ha preso decisamente il sopravvento, relegandone altre, come carte speciali o applicate, termini usati, incertamente, in precedenza. Le carte tematiche sono classificabili anzitutto in quanto lo sono i numerosissimi fenomeni terrestri: quindi carte geologiche, pedologiche, climatiche, etniche, demografiche, economiche, politiche, ecc. Ma la classificazione si può fare in altri modi. Naturalmente ogni carta tematica deve contenere un fondo topografico, che ragioni di chiarezza suggeriscono o impongono di limitare agli elementi essenziali nelle carte di media e piccola scala (coste, idrografia, confini). Tal genere di carte richiede poi, generalmente, simboli diversi da quelli delle carte del terreno, in special modo per la rappresentazione di fenomeni che ammettono una valutazione quantitativa. La distinzione tra carte tematiche e topografiche non è tuttavia assoluta. Una carta con tutte le ordinarie caratteristiche topografiche, ma che mette in speciale risalto la rete stradale e la sua qualità, e quindi un aspetto specifico degli oggetti terrestri, è una carta tematica? In fondo è un qualche cosa di transizione e si può convenientemente qualificarla carta specializzata. Anche nelle stesse carte del terreno se in piccola scala si può riscontrare una certa specializzazione, e a tal riguardo è da richiamare la vecchia distinzione scolastica fra carta fisica e carta politica. Nella prima è specialmente curata l'evidenza dell'idrografia e dell'orografia (anche per i fondi marini), nella seconda si fa spiccare la divisione politica, le città, le grandi vie di comunicazione terrestri (in genere le ferrovie). S'intende che la figurazione di certi lineamenti fisici fondamentali è necessaria anche nelle carte politiche (in particolare l'idrografia, mentre non sempre si rappresenta il rilievo). Vi sono naturalmente carte miste, fisicopolitiche. Un'altra specializzazione è tra carte che rappresentano la situazione «attuale» e quelle che invece ci mostrano quella del passato, designate coi nome di carte storiche.
VARIETA’ E CLASSIFICAZIONE DELLE CARTE TEMATICHE
Soffermiamoci ancora un momento sulle carte tematiche, la cui gran varietà risulta subito, pensando alla varietà dei fenomeni terrestri in qualche modo suscettibili di rappresentazione cartografica, almeno per quanto riguarda la loro distribuzione spaziale. Si va dai fenomeni specificamente geofisici (gravità, magnetismo, sismicità), attraverso tutta una serie di manifestazioni della natura fisiche e biologiche, sino a fatti della vita materiale e spirituale delle collettività umane (economia, costumi, religioni, organizzazione sociale e politica, ecc.). I cosiddetti atlanti nazionali, raccolte organiche di carte tematiche dirette ad illustrare cartograficamente le caratteristiche di un paese, constano di più centinaia di carte, sempre del paese stesso, ossia di un medesimo territorio. Le carte tematiche si possono perciò distinguere in gruppi secondo il campo dei fenomeni considerati, in sostanza le diverse discipline scientifiche e i loro rami; poi secondo il carattere generale del tema e dei temi rappresentati, ed abbiamo allora carte qualitative e quantitative, statiche e dinamiche; secondo il numero dei fenomeni figurati in una stessa carta e i loro rapporti; infine si distinguono per il modo d'origine. Le carte qualitative rappresentano i fenomeni nelle loro peculiari caratteristiche, anzi spesso soltanto di una sola di queste: età e natura litologica nelle carte geologiche, tipi di vegetazione, lingue e religioni, coltura di determinate specie vegetali, presenza di certi minerali, ecc. Qualitativa è anche, per esempio, una carta che classifica i centri abitati secondo la loro posizione topografica. Al solito la carta non rappresenta la qualità in sé, bensì la sua distribuzione spaziale. Le carte quantitative, quantificato il fenomeno o certe sue manifestazioni, mostrano una grandezza assoluta o relativa od anche un ordine di successione o gerarchia: ne sono esempi le carte della temperatura dell'aria e della quantità di precipitazioni, la popolazione dei singoli centri abitati o delle regioni, le carte della densità di popolazione, quelle della produzione di certe derrate agricole in base al raccolto annuo, ecc. Sono chiamate carte analitiche quelle che si appuntano su un solo tema o ad una singola manifestazione di esso, od anche a più temi affini dei quali sia possibile formare un'unica categoria; le carte complesse riuniscono più temi o più manifestazioni di uno stesso fenomeno; quelle sintetiche nascono dalla combinazione di più temi, con l'intento di illustrare delle correlazioni, oppure esprimono una tipologia. Specialmente le carte sintetiche mirano a rendere conto dei risultati di studi o cercano di dare una visualizzazione esplicativa di certi fenomeni. Ma in altro senso tutte le carte tematiche possono considerarsi sintetiche, in quanto esse rappresentano, visualizzandoli, un gran numero di dati. Ciò specialmente per le carte quantitative, di cui facciamo due esempi: una carta delle precipitazioni annue (quantità) in Italia è stata costruita in base a 4000 dati pertinenti ad altrettante stazioni, una carta della densità di popolazione riassume ben 8000 dati, cioè quelli spettanti ai singoli Comuni del nostro Paese.
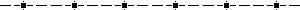
Carta disegnata, ortofotocarta e cartografia numerica
Per carta disegnata si intende il tipo di carta topografica comunemente prodotta e utilizzata; sono tali ad es. la carta Igm alla scala 1:25000, la carta catastale, le carte comunali alla scala 1:2000, e così via. La carta viene ricavata o con procedimento di rilevamento a terra mediante strumenti topografia o da fotografie aeree mediante un restitutore fotogrammetrico. Contrariamente alla carta disegnata, realizzabile sia con il metodo topografico che con quello fotogrammetrico, la fotocarta deriva sempre da riprese fotografiche aeree; ed è ricavata deformando l'immagine che si ottiene dalla fotografia in modo che assuma la caratteristica propria delle carte topografiche e fotogrammetriche di rappresentare la superficie del terreno come se fosse proiettata su un piano orizzontale, cioè su un piano ortogonale alla direzione media della verticale della zona rappresentata. Mentre però nelle carte disegnate ogni particolare del terreno è rappresentato in pianta, nella fotocarta questo non avviene perché essa è derivata direttamente dall'immagine fotografica e quindi conserva la visione prospettica delle cose che è propria delle proiezioni centrali, quali sono appunto le fotografie.
Al giorno d'oggi tutta la documentazione topografica viene ottenuta e sviluppata per mezzo del calcolatore. Per approfondire questo argomento rimandiamo il lettore alla pagina delle Prescrizioni Tecniche.
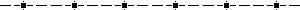
Originali o primarie sono anzitutto le carte provenienti direttamente da operazioni di rilevamento topografico sul terreno o dalla restituzione di fotografie aeree. Da queste carte di rilevamento se ne ricavano altre in scala minore e semplificate oppure con diverso «stile» di figurazione, ed esse prendono il nome di carte derivate. La distinzione riguarda in primo luogo le carte del terreno, come la carta al 25.000 del territorio italiano dell'Istituto Geografico Militare, i cui fogli erano indicati col nome di levate di campagna, in quanto disegnate sui luoghi. Sono invece carte derivate quelle in scala 1:50.000 e 1:100.000 dell'Istituto stesso. La derivazione non esclude l'apporto d'integrazioni e aggiornamenti. Originale può essere però anche una carta risultante dal razionale coordinamento ed elaborazione di materiale cartografico diverso, ed eventualmente da dati vari di altro genere. Nel vasto campo delle carte tematiche, non ne mancano affatto di derivate, ma spesso si tratta di carte originali, perché fondate su indagini apposite in loco, che possono essere veri e propri rilevamenti finalizzati al tema da rappresentare (rilevamenti geologici, geomorfologici, pedologici, botanici, ecc.); oppure la base di redazione è fornita da dati di diversa natura e specialmente statistici. Su questi ultimi, sono fondate, ad esempio, le carte della distribuzione e delle variazioni della popolazione. Anche le carte climatiche si basano su dati numerici, provenienti dalle osservazioni meteorologiche.
INFLUENZA DEL RAPPORTO DI SCALA SULLA PRECISIONE E SUL GRADO DI DETTAGLIO DI UNA CARTA DI BASE
Il contenuto d'informazioni di tipo qualitativo di una carta di base e la precisione delle misure su di essa eseguibili dipendono dal suo fattore di scala, cioè dal rapporto di riduzione con il quale vengono rappresentate le grandezze lineari; si dice che la scala di una carta è tanto più piccola quanto più piccole sono, rispetto alla realtà, le dimensioni di ciò che essa rappresenta. Per quanto riguarda la scala le carte di base si dividono in tre categorie - a grande, media e piccola scala - prive di confini ben definiti; noi adotteremo i seguenti: carte a grande scala 1:500; 1:1000; 1:2000; carte a media scala 1:5000, 1:10.000; carte a piccola scala da 1:25.000 in poi.
Dalla scala della carta dipendono i due parametri che la caratterizzano dal punto di vista metrico.
1. il suo grado di risoluzione, cioè la dimensione lineare del particolare più piccolo rappresentabile sulla carta. E’ dato dal minimo spessore del tratto grafico con cui la carta viene disegnata e che viene assunto, per convenzione, uguale a 0,2 mm, moltiplicato per il fattore di riduzione; ad esempio per una carta alla scala 1:10000 il grado di risoluzione è di 2 m e cioè non è possibile rappresentare sulla carta particolari del terreno inferiori a tale grandezza;
2. l'errore massimo che si commette nel rilevare da essa la posizione di un punto: si conviene che esso debba essere inferiore al prodotto di 0,5 mm per il rapporto di riduzione della carta; per una carta alla scala 1:10000 ad es. l'errore massimo di posizionamento di un punto vale 5 m.
La realizzazione delle carte richiede che vengano impiegati in larga misura segni convenzionali, cioè una serie di simboli che non stanno nel giusto rapporto con le dimensioni reali degli oggetti.
Al diminuire della scala della carta, cioè con l'aumentare del rapporto di riduzione, si ha quindi un minor contenuto d'informazione in termini qualitativi e metrici; d'altra parte però col diminuire della scala si produce sulla carta una specie di semplificazione, che cancella quanto ne costituisce la tessitura minuta ed esalta i tratti più importanti del territorio; inoltre aumenta, a parità di dimensioni del foglio, la zona reale di territorio rappresentata. Pertanto, se è vero che le grandi scale consentono un grado di lettura molto fine del territorio, è anche vero che quelle a piccola scala permettono una visione di insieme che le prime non danno.